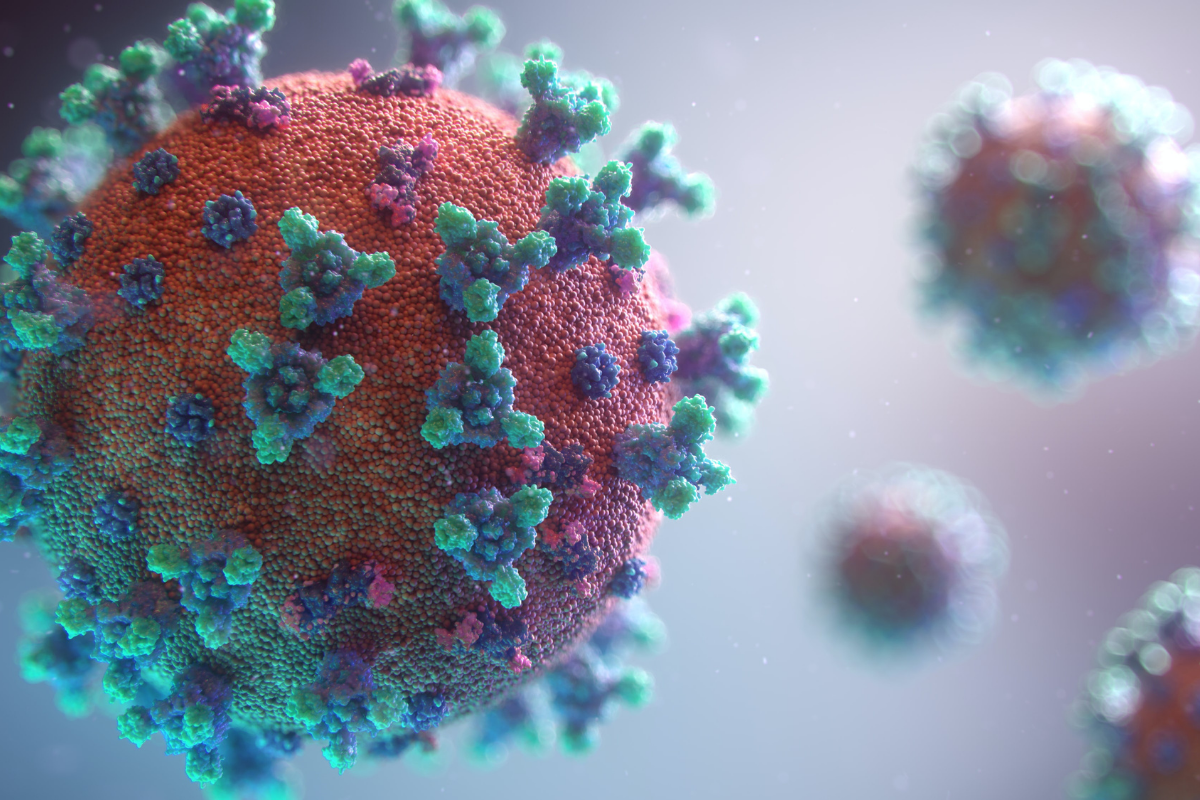Approccio sistemico relazionale: origini ed elementi fondanti

La psicoterapia sistemico relazionale considera l’individuo come entità unica e intera, imprescindibile dal contesto culturale, sociale e relazionale in cui esso è inserito. L’ambiente familiare ha un ruolo predominante sulle altre sfere che compongono il sistema relazionale. In questa ottica, la psicoterapia sistemica si contrappone alla metodologia ortodossa della psicoanalisi, in quanto il singolo viene letto all’interno della relazione di tutti gli attori dei contesti di sua appartenenza.
Quali sono gli elementi su cui basa l’approccio sistemico relazionale dalle teorie tradizionali psicoanalitiche?
Lo spieghiamo in questo articolo, partendo dal contesto storico culturale in cui la teoria fu partorita.
La teoria sistemica: origini dell’approccio sistemico relazionale
Formulata dal biologo austriaco Ludwig Von Bertalanffy, la teoria sistemica è stata applicata alla cibernetica, alla psicologia e alla meccanica. Secondo tale teoria sistemica, i sistemi sono formati da parti in interazione tra loro secondo un rapporto circolare, e non lineare di causa-effetto. L’effetto di un cambiamento all’interno del sistema non si ripercuote univocamente sulla parte interessata, ma su tutte le parti che compongono il sistema stesso.
Gregory Bateson, antropologo inglese, è considerato uno dei padri fondatori della concezione relazionale sistemica applicata alla psicologia e alle scienze sociali, nonché uno dei maggiori esponenti della Scuola di Palo Alto. Bateson è conosciuto per aver applicato le sue conoscenze etnologiche e antropologiche alla psichiatria, in particolare la teoria sistemica.
Bateson fu uno dei primi studiosi a concepire l’individuo come soggetto contestuale. Secondo lo studioso, infatti la soggettività deve essere intesa come la somma delle interazioni dell’ambiente in cui l’individuo è inserito e delle sue relazioni con altri. Novità rispetto alla psicoanalisi tradizionale secondo la quale l’individuo invece è visto come una monade separata.
Non si può non comunicare: l’influenza della Scuola di Palo Alto
Un ulteriore aspetto innovativo all’interno della teoria sistemico relazionale è l’importanza che viene attribuita alla comunicazione, influenza degli studi della Scuola di Palo Alto. Tra questi il primo dei cinque assiomi della comunicazione: non si può non comunicare. Per quanto un soggetto non esprima la sua volontà di comunicare, attraverso per esempio i suoi silenzi, esso sta comunicando di non voler comunicare, inviando in ogni caso un messaggio all’interlocutore. Dunque la non comunicazione secondo il primo assioma della comunicazione, non è possibile.
Ogni nostro atteggiamento comunica agli altri un messaggio rivelando degli aspetti di noi stessi. Che importanza ha tale assioma all’interno della teoria sistemico relazionale? La diretta conseguenza di questo assioma è che ogni decisione e gesto del singolo devono essere letti come un messaggio agli altri componenti del sistema in cui il singolo stesso è inserito.
Il disagio secondo la teoria sistemico relazionale
Il concetto di sintomo, diagnosi e trattamento cambia rispetto alla teoria psicoanalitica. Il sintomo diventa il messaggio che il singolo tramette al suo sistema di riferimento, manifestando un disagio del sistema stesso. Il sintomo è segnale di una disfunzionalità all’interno del sistema di riferimento. Secondo la teoria sistemica dunque il disagio personale del paziente è risultato di una disfunzione del sistema relazionale di riferimento. Un sistema complesso, influenzato dal vissuto del singolo e dai suoi desideri legati al futuro e dalle sue esperienze relazionali. Il disagio dunque non nasce per forza da traumi ed esperienze negative del singolo, quanto piuttosto da disfunzioni del sistema di riferimento, quali possono essere famiglia, dimensione di coppia o contesto lavorativo.
Ecco che in quest’ottica la famiglia è il sistema per eccellenza costituito da membri che con le loro azioni influenzano il sistema stesso, con ripercussioni anche sul singolo individuo. Il terapeuta della scuola sistemico relazionale leggerà il disagio della persona tenendo conto in primis delle sue relazioni familiari.
Quanto dura una terapia sistemico relazionale?
A questa domanda non c’è una risposta univoca: dipende da caso a caso. La terapia inizialmente di solito viene svolta una volta alla settimana, con una durata intorno ai 60 minuti per seduta. I fattori che influiscono sulla durata di una terapia sistemico relazionale, come qualsiasi terapia, sono molteplici: la relazione terapeutica, gli obiettivi prefissati e concordati inizialmente con il terapeuta e la qualità del lavoro durante le sedute.